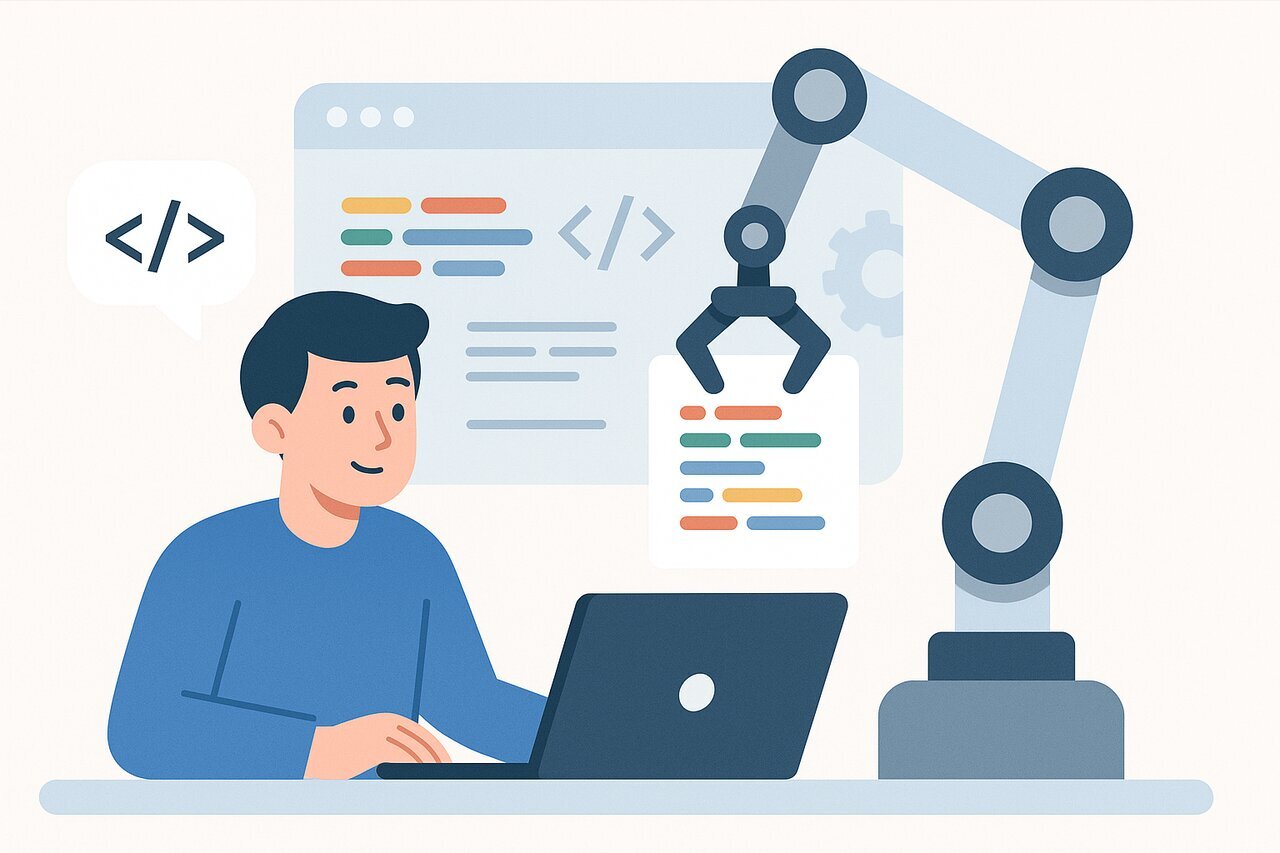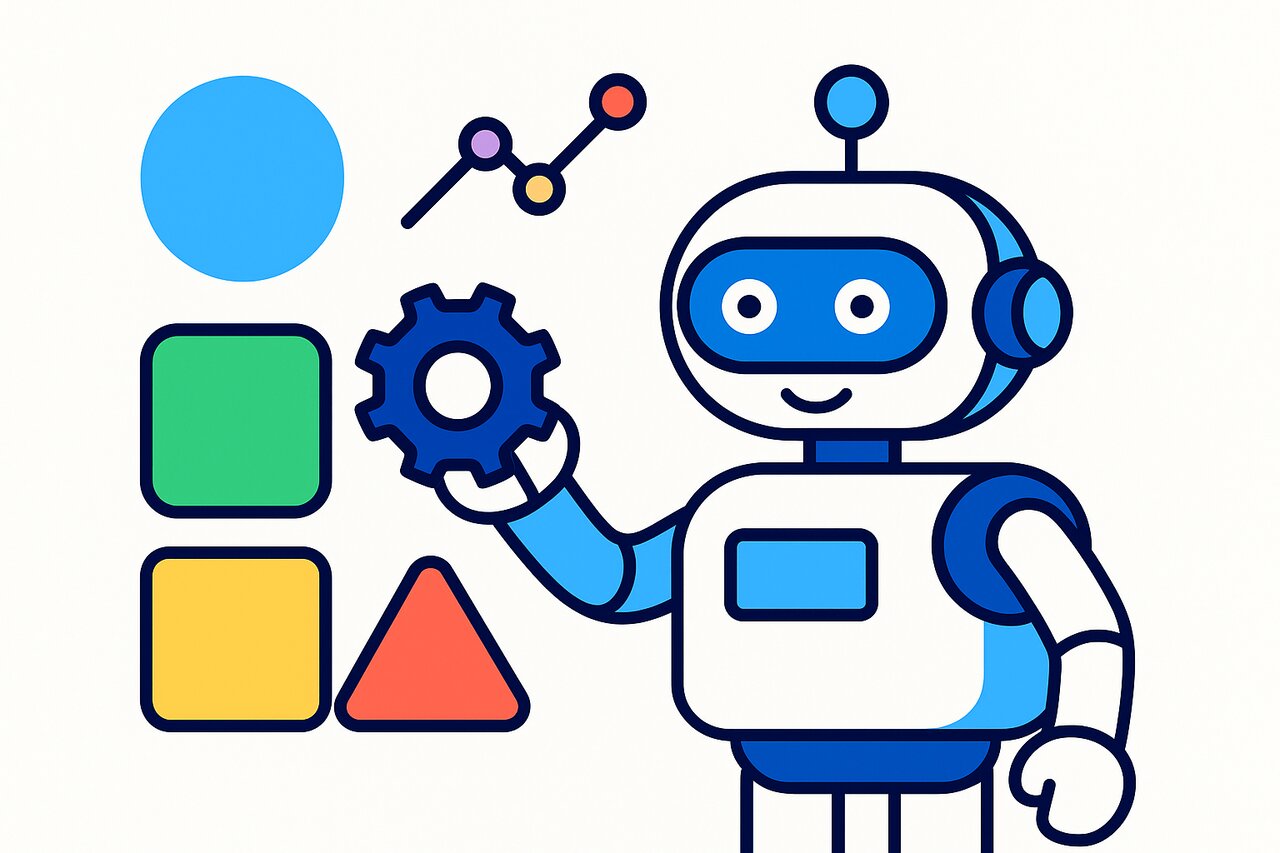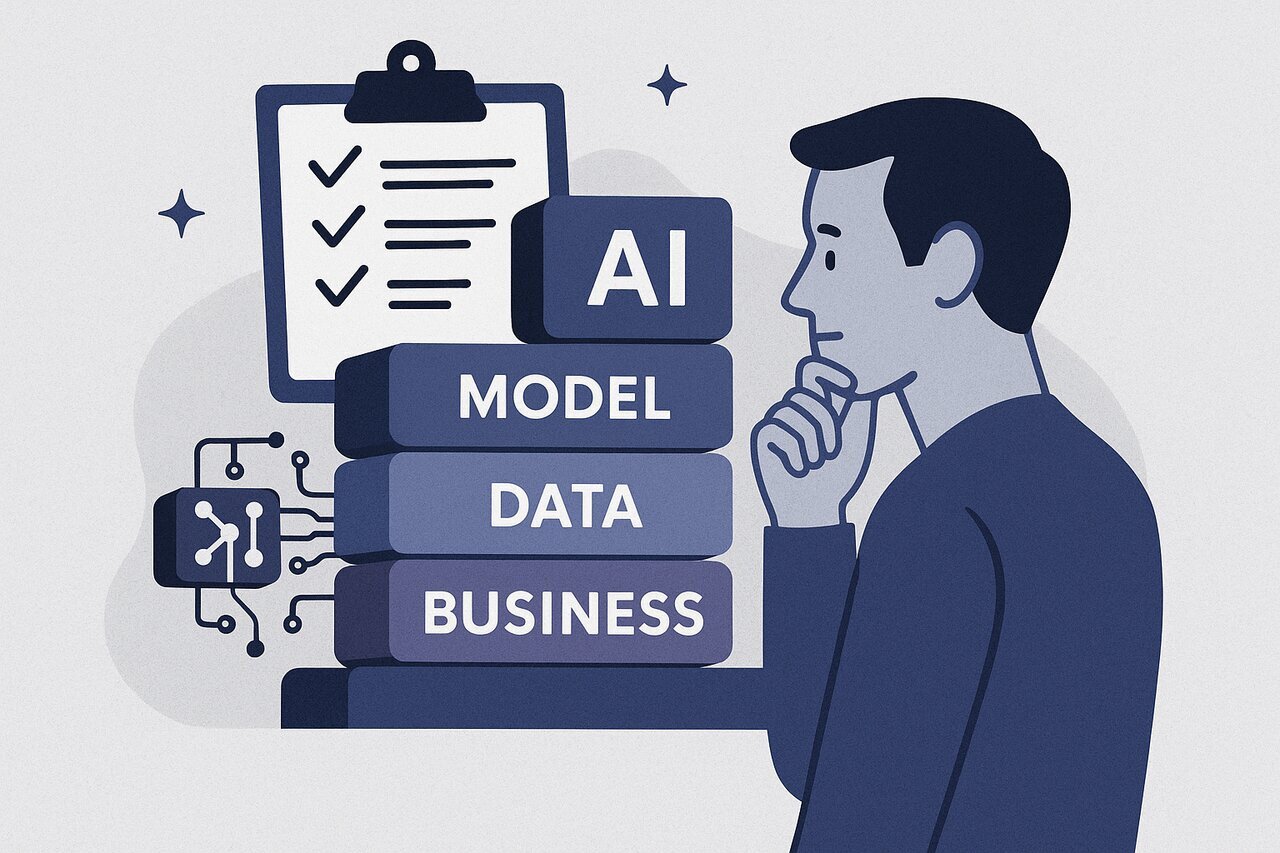Indice
- Introduzione
- Perché l’AI amplifica il rischio di debito tecnico
- Dove l’AI funziona davvero bene
- Dove serve prudenza
- Un criterio utile: Buy vs Build vs AI-Build
- Come impostare guardrail efficaci senza rallentare
- Un processo sprint-per-sprint che regge in produzione
- Un esempio concreto: “Stock Gateway” B2B
- Come riconoscere che il debito sta crescendo
- Misurare per decidere
- AI policy di team: poche regole, scritte e condivise
- Il ruolo del GamePlan Workshop
- FAQ
- Conclusioni
Introduzione
Negli ultimi mesi molte aziende hanno sperimentato assistenti di sviluppo basati su AI generativa. Il risultato è evidente: i team scrivono codice più velocemente, esplorano più soluzioni in meno tempo, automatizzano parti di lavoro che prima richiedevano giorni.
Ma c’è un rovescio della medaglia di cui si parla poco: quando la velocità non è accompagnata da regole chiare e da pratica ingegneristica, il codice cresce in fretta ma in modo disordinato. Più superficie, più accoppiamenti, più dipendenze. È così che nasce il debito tecnico.
La domanda quindi non è se usare o no l’AI, bensì come metterla a terra per ottenere risultati senza trasformare il codebase in un groviglio fragile e costoso da manutenere.
Perché l’AI amplifica il rischio di debito tecnico
La generazione automatica rende facile creare “buon” codice che compila e passa i primi test, ma che spesso ignora vincoli non funzionali e invarianti architetturali. Un assistente può proporre un’API elegante per un microservizio, e nello stesso tempo dimenticare timeouts, politiche di retry, osservabilità, gestione degli errori, limiti di memoria o costi cloud.
Il problema non è l’errore singolo: è la somma di piccoli compromessi che si accumulano sprint dopo sprint. Inoltre l’AI apprende da esempi pubblici non sempre aggiornati; in aree come build, IaC o pipeline CI/CD la qualità media dei materiali di training è eterogenea.
Se non si danno guardrail precisi, il rischio è replicare pattern datati o anti-pattern senza che nessuno se ne accorga subito.
Infine c’è la dinamica umana: quando “l’ha scritto l’AI”, l’ownership psicologica si indebolisce. Il refactoring viene rimandato perché “intanto funziona”. È così che il debito diventa interesse composto.
Dove l’AI funziona davvero bene
Esistono contesti in cui l’AI è un acceleratore sano. Pensiamo al codice “collante”: adapter, mapping tra DTO, client SDK, serializers, migrazioni dati con regole chiare.
Qui il valore è nella ripetibilità più che nella brillantezza architetturale. L’AI consente di partire con uno scheletro funzionante in poche ore, che poi il team rinforza con test e osservabilità.
Lo stesso vale per la documentazione iniziale, per esempi d’uso e READMEs: partire da una bozza consente di spostare energie sulla parte critica del sistema.
Anche la fase di esplorazione beneficia molto: prototipi rapidi per validare un’idea, da buttare e rifare “per bene” appena l’ipotesi regge.
Dove serve prudenza
All’estremo opposto ci sono i componenti che differenziano il business o che sostengono requisiti non funzionali severi: motori di regole, pricing, personalizzazione real-time, pipeline a bassa latenza, sicurezza e compliance, gestione di dati sensibili, transazioni distribuite.
Qui l’AI può affiancare, non sostituire, l’ingegnere esperto. Il motivo è semplice: serve la capacità di pesare compromessi invisibili al modello (“quanta latenza in più accetto per semplificare il protocollo?”) e di mantenere coerenza con il resto dell’ecosistema tecnologico.
Un criterio utile: Buy vs Build vs AI-Build
Un modo pratico di decidere è distinguere tra software strategico e utility.
Nel primo caso la tecnologia crea vantaggio competitivo; nel secondo risolve esigenze comuni.
Per ciò che è utility conviene prima valutare il mercato: se esiste un SaaS affidabile, acquistare riduce TCO e debito futuro.
Se non esiste, l’AI può aiutare a scaffoldare rapidamente un servizio, purché il team si prenda l’onere di test, sicurezza e osservabilità.
Per ciò che è strategico l’AI diventa un pair che accelera, ma le decisioni restano in mano al team. In entrambi i casi è essenziale lasciare traccia con brevi ADR: obiettivo, opzioni considerate, trade-off, criteri di successo.
Come impostare guardrail efficaci senza rallentare
Il punto non è ingessare il lavoro, ma stabilire poche regole semplici che abbassano il rischio.
La prima riguarda il modo di lavorare: trunk-based development, batch piccoli, pull request atomiche e veloci da rivedere. L’AI tende a proporre patch ampie; occorre abitudine a spezzare la consegna in passi logici: interfacce, test, implementazione, hardening.
Secondo: test visibili all’AI. Se lo strumento vede i contratti tra servizi e i test d’integrazione, è più probabile che rispetti le assunzioni del sistema.
Terzo: prompt con contesto. Non basta “scrivi un client HTTP”; servono vincoli (“timeout 500ms, 3 retry con backoff, log strutturati, tracing con header X”).
Quarto: code review consapevole. La checklist deve includere concorrenza, gestione dell’errore, risorse, costi, metriche e logging.
Quinto: observability by design. Ogni rotta nuova porta con sé log strutturati, metriche essenziali e trace end-to-end; senza visibilità, il debito si nasconde e cresce.
Un processo sprint-per-sprint che regge in produzione
In un progetto mission-critical il ciclo tipico potrebbe essere il seguente.
Si parte da un breve design brief che esplicita requisiti non funzionali e invarianti (SLO, limiti di latenza, idempotenza, policy di errore).
Si scrivono test e contratti prima del codice. Si usa l’AI per generare lo scheletro e per produrre variant fini (ad es. mapping ripetitivi), poi si passa a una fase di hardening: completamento manuale, pulizia, gestione degli errori, inserimento di log e metriche, messa in sicurezza delle dipendenze.
La consegna avviene tramite PR piccole, feature flag e progressive delivery.
Infine, a fine sprint, una retro ingegneristica chiede esplicitamente: quale debito abbiamo introdotto? Su quali moduli? Quanto impatta i nostri SLO? Cosa dobbiamo ripagare prima del prossimo incremento?
Un esempio concreto: “Stock Gateway” B2B
Immaginiamo un gateway che espone disponibilità di magazzino a siti e app. Non è il cuore del business, ma è fondamentale per evitare ordini impossibili da evadere.
L’AI può generare controller, client verso l’ERP, mapping e i primi test contrattuali.
Il team completa con politiche di timeout e retry, circuit breaker, idempotenza, log strutturati e tracing.
Il risultato è un avvio più rapido del 50–60% rispetto a un’implementazione full-manuale, con un debito sotto controllo perché ciascun passo è accompagnato da test e osservabilità.
Come riconoscere che il debito sta crescendo
I segnali ci sono e sono piuttosto chiari.
- Pull request sempre più grandi e difficili da rivedere.
- Dipendenze aggiunte senza una ragione evidente.
- Pipeline che rallenta perché i test diventano fragili e intermittenti.
- Incidenti che richiedono “archeologia del codice” per capire cosa succede.
- Crescita del tempo di ripristino e delle violazioni agli SLO.
Quando il team inizia a dire “non tocchiamo quella parte perché nessuno la capisce davvero”, il debito è già diventato interesse.
Misurare per decidere
Il modo più efficace per evitare dibattiti astratti è mettere a terra alcune metriche.
Le DORA (lead time, frequenza di rilascio, MTTR) raccontano la salute del flusso.
L’osservabilità dice se gli SLO sono rispettati.
A livello di codice, vale la pena monitorare coverage utile sui file toccati, churn anomalo dopo rigenerazioni, tempo medio di review, percentuale di PR piccole.
Non servono cento numeri: ne bastano pochi, coerenti e visibili al team, per capire quando fermarsi a consolidare.
AI policy di team: poche regole, scritte e condivise
Ogni team dovrebbe avere un documento leggero che chiarisce tre cose.
Primo: cosa si può generare in autonomia (es. adapter, test di contorno) e cosa richiede coinvolgimento senior.
Secondo: come si gestiscono proprietà intellettuale e privacy; i prompt non devono contenere dati sensibili o segreti.
Terzo: tracciabilità minima dei prompt e dei risultati, in modo da poter ricostruire a posteriori come è nato un modulo. Non serve burocrazia, serve chiarezza.
Il ruolo del GamePlan Workshop
Molte criticità nascono prima della prima riga di codice. Un GamePlan Workshop efficace allinea business, marketing e IT su architettura, SLO, standard, check di sicurezza e pipeline.
È anche il momento giusto per definire come useremo l’AI: dove accelera, dove la escludiamo, quali metriche useremo per valutare l’impatto, come gestiremo refactoring e rollback. Un giorno speso qui ne risparmia molti quando la piattaforma è in produzione.
FAQ
L’AI va esclusa dai componenti core?
No. Va usata come acceleratore sotto la guida di persone esperte. Nel core la generazione è un punto di partenza, non la consegna.
Come evitiamo pull request monolitiche generate dall’AI?
Programmiamo la generazione in step, consegniamo per piccoli incrementi e usiamo strumenti che aiutano a spezzare i cambiamenti in patch coese e testabili.
IaC, build e pipeline generati dall’AI sono affidabili?
Spesso al primo tentativo no. Servono lint, policy-as-code, ambienti di prova e un catalogo interno di frammenti “approvati” da riutilizzare.
Quando ripagare il debito?
Quando impatta cambiabilità e SLO. Il resto si gestisce con il principio “boy-scout”: ogni volta che tocchiamo un modulo lo lasciamo un po’ meglio di come l’abbiamo trovato.
L’AI sostituirà gli sviluppatori junior?
Cambierà il percorso di crescita. Scrivere codice sarà solo una parte; cresceranno di peso lettura critica, design, osservabilità, diagnosi e decisioni architetturali.
Conclusioni
L’AI generativa non è di per sé una fabbrica di debito tecnico. Lo diventa quando la velocità non è accompagnata da pratica ingegneristica e guardrail.
Con regole semplici, test prima del codice, osservabilità integrata e consegne piccole, i team possono raccogliere i benefici senza compromettere la sostenibilità del software.
La domanda iniziale era se l’AI creerà montagne di debito. La risposta corretta è: può farlo, ma non è inevitabile. Dipende dalla disciplina con cui la integriamo nel modo di lavorare.
Se vuoi introdurre l’AI in modo sicuro e misurabile nei tuoi processi di sviluppo, inizia da un GamePlan Workshop: un check-up operativo che definisce policy, metriche e flussi, prepara pipeline, test e osservabilità, e stabilisce dove l’AI accelera davvero senza aumentare il rischio.